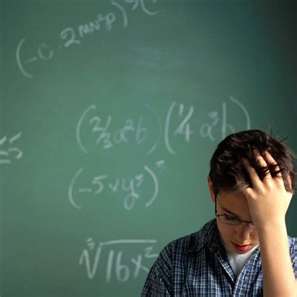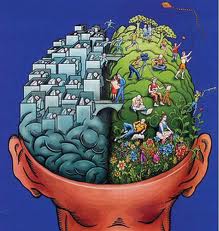|
||||||||||
|
Ritardo mentale lieve: un’etichetta molto problematica Margherita Orsolini Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Sapienza Università di Roma
Avete sentito parlare di “ritardo mentale lieve” o “disabilità intellettiva lieve”? Sicuramente sì, perché questa diagnosi riguarda circa l’1% dei bambini, costituisce uno dei motivi più frequenti per consultare un neuropsichiatra infantile, e una delle principali ragioni per l’assegnazione di un insegnante di sostegno. Potreste con ragione pensare che siano ben note le caratteristiche dei bambini con questa diagnosi: un quoziente intellettivo (QI) basso; scarse abilità di ragionamento; difficoltà ad adattarsi a situazioni sociali nuove, ad inserirsi in giochi e conversazioni tra pari; scarsa autonomia e ansia quando ci sono cambiamenti nelle routines di vita quotidiana. Difficoltà ad apprendere concetti e abilità complesse. Tutto questo vi aspettate da una diagnosi neuropsichiatrica che ha un’antica tradizione, antica almeno quanto lo sono i test che misurano l’intelligenza.
1. QI e intelligenza L’idea che il nucleo essenziale del “ritardo mentale lieve” possa cogliersi attraverso il QI si basa sulla convinzione che il QI possa essere un buon indicatore dell’intelligenza. Alcuni studiosi (Carroll, 1993) però non sono MAI stati d’accordo con l’idea di un’ intelligenza generale e hanno invece affermato che ci sono tante specifiche abilità alla base dei punteggi che concorrono al QI. Un QI deficitario può essere il risultato di carenze in un insieme di abilità e conoscenze.
4. Attenzione e apprendimenti L’apprendimento, anche quello più specifico, richiede l’efficienza di alcune funzioni attentive: saperdedicare attenzione consapevole a un compito, controllare informazioni o risposte che possono essere in conflitto tra loro, alternare l’attenzione tra tipi di informazioni diverse a cui applicare procedure o regole, mantenere in memoria una serie di informazioni visive o verbali. Queste importanti funzioni sono in genere carenti nelle persone con QI deficitario (Jarrold et al. 2000; Lanfranchi et al. 2004, 2009; Vicari et al., 2006; Schneider et al., 2009; Schuchardt et al., 2010). Ma queste funzioni possono essere molto potenziate con opportune strategie di intervento.
6. Immagine di sé e apprendimento Un essere umano che ha appreso a considerarsi non intelligente ha paura di fronte a situazioni nuove. Ha paura di venire in contatto con un’immagine di sé interpretata come inabile e incompetente; ha paura di sperimentare un’umiliante vergogna che provoca una condanna interna, un senso di confusione e insicurezza. Dati questi sentimenti, la tendenza di molti ragazzi con “disabilità intellettiva” e dei loro genitori è di proteggersi dalle novità e dalle situazioni complesse, di rifugiarsi in consolanti routines sia nella vita sociale sia nelle situazioni d’apprendimento.
7. Non so le cose perché debbo ancora impararle o perché non sono intelligente? Leggete che cosa diceva Fabrizio (nome fittizio) di se stesso, nel corso dell’intervento che abbiamo compiuto con lui e la sua famiglia, riuscendo a modificare sostanzialmente la sua capacità di fare ipotesi, affrontare problemi e ragionamenti, interagire con i pari.
L’ estratto verte su una decisione che Fabr. (15 anni) e la sua famiglia dovevano prendere a proposito del trasferimento da un istituto professionale ad un altro. Ricominciare dal primo anno o trasferirsi in una classe di secondo anno? FABR.: tanto non importa, tanto gli altri sono sempre più intelligenti. ADULTO: che cosa? Che hai detto? ((scherzando, marcando esageratamente le espressioni del viso)) FABR.: che gli altri sono sempre più intelligenti. ADULTO: tu pensi questo? Pensi questo? FABR.: ((sorride)) ADULTO: sono più intelligenti in tutto? FABR.: sì ((sorride)) ADULTO: ((abbassa la testa e fa un lungo sospiro)) ma io vorrei sapere perché… noi lavoriamo e tu però pensi sempre queste cose negative, FABR. FABR.: non lo so ((sorride)) ADULTO: ma tu spiegami una cosa, non c’è una cosa in cui ti senti intelligente? FABR.: quando faccio le cose da solo mi sento intelligente. ADULTO: ah…e come mai allora? FABR.: quando non so le cose, non mi sento. ADULTO: ah, quando non sai le cose pensi “non sono intelligente”. Invece non è che pensi “non so le cose perché le devo ancora imparare”. Non è che pensi che puoi imparare, non lo pensi mai questo, che puoi imparare? FABR.: non l’ho mai pensato ((sorride))
8. L’importanza del linguaggio Ci sono bambini il cui QI deficitario è determinato da una storia di specifiche difficoltà con il linguaggio unite a difficoltà di concentrazione e di regolazione emotiva. Per questi bambini gli ostacoli nell’apprendimento si evidenziano all’inizio della scuola primaria, quando attività complesse non trovano un efficiente supporto attentivo o di organizzazione delle azioni e del comportamento, o di elaborazione linguistica. 9. L’importanza di ricostruire la storia evolutiva del bambino Alcuni bambini hannoinvece avuto, fin dalla prima infanzia, difficoltà in una vasta ma variabile gamma di funzioni cognitive. Queste difficoltà possono essere prodotte da condizioni genetiche, neurobiologiche e ambientali. Valutare un bambino o un ragazzo è un’impresa più complessa di quella che si basa sulla determinazione del QI e del livello di funzionamento adattivo dell’individuo.
10. Gli interventi con bambini che hanno difficoltà in tanti tipi di apprendimenti ha bisogno di svariate condizioni · Attività riabilitative costruite per stimolare funzioni cognitive specifiche (ad esempio, per stimolare l’attenzione o la memoria a breve termine); · Una relazione adulto-bambino che faciliti il coinvolgimento emotivo, la fiducia nella possibilità di affrontare compiti complessi; · Un contesto scolastico che aiuti il bambino a stabilire relazioni con i compagni e a pensarsi come bambino che può avere difficoltà ad apprendere senza per questo essere poco intelligente; · Un contesto familiare che impari a dare nomi più appropriati alle difficoltà del bambino (es., nomi come distrazione, memoria, impulsività, scarsa pianificazione e organizzazione, lentezza nel recuperare dalla memoria le parole da dire); · Un contesto familiare che non perda la fiducia nella capacità del bambino di pensare, che non rinunci a proporre stimoli e apprendimenti nuovi, che non si vergogni dello sbagliare, che impari la pazienza del costruirsi dell’imparare.
Riferimenti bibliografici Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge, England: University of Cambridge Press. Cornoldi, C. (2007) L’intelligenza. Bologna: Il Mulino. Di Nuovo, S. e Buono, S. (2010) Strumenti psicodiagnostici per il ritardo mentale. L'assessment psicologico nella disabilità intellettiva. Milano: Franco Angeli. Dierssen, M., Benavides-Piccione, R., Martínez-Cué, C., Estivill, X., et al. (2003) Alterations of neocortical pyramidal cell phenotype in the Ts65Dn mouse model of Down syndrome: effects of environmental enrichment. Cerebral Cortex, 13(7), 758-64. Irwin, S.A., Galvez, R. & Greenough, W.T. (2000) Dendritic Spine Structural Anomalies in Fragile-X Mental Retardation Syndrome. Cerebral Cortex, 10, 1038-1044. Jamie O. Edgin, J. O., Pennington, B. F. & Mervis, C. B. (2010)Neuropsychological components of intellectual disability: the contributions of immediate, working, and associative memory.jof Intellectual Disability Research,54 (4), 406-417. Jung, R.E. & Haier, R.J. (2007) The Parieto-Frontal Integration Theory (P-FIT) of intelligence: Converging neuroimaging evidence.Behavioral and Brain Sciences, 30, 135–187. Neisser , U., Boodoo, G., Bouchard, Jr.,T.J., Boykin, A. W., Brody, N. et al.(1996)Intelligence: Knowns and Unknowns. American Psychologist, 2, 77-101. Orsolini, M. (a cura di) (2012) La valutazione e l’intervento con D.: disabilità intellettiva o disturbo generalizzato dell’apprendimento?Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 79, 178-194. Restivo, L., Ferrari, F., Passino, E., Sgobio, C., et al. (2005) Enriched environment promotes behavioral and morphological recovery in a mouse model for the fragile X syndrome. Proceedings of the National Academy of Science U. S. A., August 9;102(32), 11557-62. Rodrigues A. C. T. & Banzato C. E. M. (2009) A logical-pragmatic perspective on validity. Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences, 2(2): 40-44. Ruggerini, C., Dalla Vecchia, A. & Vezzosi, F. (2008) Prendersi cura della disabilità intellettiva. Trento: Erikson. Schuchardt K., Gebhardt M., Mäehler C. (2010) Working memory functions in children with different degrees of intellectual disability. Journal of IntellectualDisability Research,54 (4), 346-53. Vianello, R. (2004). Ritardo mentale: molteplicità di forme. Aspetti cognitivi, comportamentali e motivazionali. In R. Vianello, M. Mariotti e M. Serra (a cura di). Ritardo mentale e autismo. Studi, ricerche e proposte operative (pp. 39-48). Bergamo: Edizioni Junior. Vicari S., Bellucci S., Carlesimo G. A. (2006) Evidence from two genetic syndromes for the independence of spatial and visual working memory. Developmental Medicine and Child Neurology,48 (2), 126-31. Wechsler, D. (1991) WISC-III: Wechsler intelligence scale for children. New York, The Psychological Corporation (trad. It. Arturo Orsini e Laura Picone, Firenze: Organizzazioni Speciali, 2006).
|